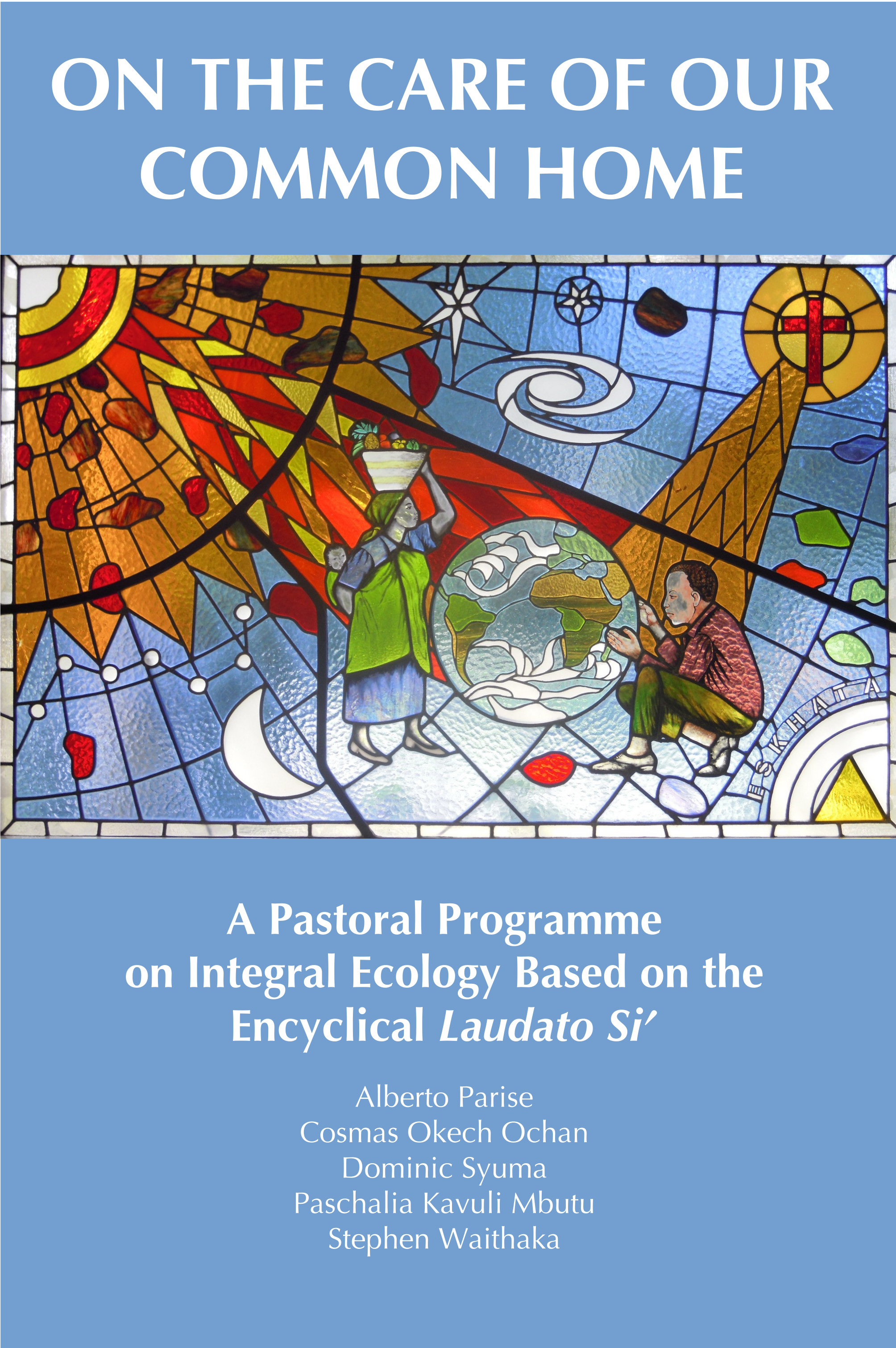Lo scorso 7 maggio, la comunità della Curia ha dedicato una giornata di ritiro per nutrire la propria spiritualità ecologica.
Premesse:
= “Siamo tutti nella stessa barca”: l’esperienza della pandemia ci ha resi consapevoli di come «tutto è connesso» (cf. LS 117). O ci salviamo insieme, o non si salva nessuno.
= «L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune».
= Invece oggi tutto divide, ci troviamo di fronte a una forte polarizzazione, conflittualità e frammentazione della realtà. Camminare assieme, sia come chiesa che come società e comunità internazionale appare sempre più difficile.
= Comboni nella realtà del suo tempo aveva già colto questo tipo di dinamiche. Il suo Piano aveva un carattere assolutamente “sinodale”, nel rispetto delle diversità dei carismi, ma con un progetto comune di evangelizzazione dell’Africa.
La conversione ecologica
Oggi siamo chiamati ad una conversione ecologica, che significa riconciliazione con Dio, con l’umanità e con il creato, nella consapevolezza che tutto è connesso. Papa Francesco usa l’espressione “ecologia integrale”, sottolineando che è inclusiva di tutti gli aspetti della realtà, non solo ambientali, ma anche socio-economici, culturali, spirituali, politici ecc.1
Ma è un percorso che è possibile solo se lo facciamo assieme.
Il Capitolo ci invita a fare questo cammino, che si può realizzare se nasce da una autentica conversione comunitaria, da un cammino condiviso che risponda agli inviti dello Spirito.
Contempliamo questa situazione nel passo di Gv 20, 19-23:
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”.
I discepoli di Gesù – disorientati, impauriti, bloccati in un autoisolamento – fanno assieme un’esperienza della presenza del Risorto in mezzo a loro. Tre sottolineature:
1. È un’esperienza che cambia tutto: nel dono della pace – shalom – sperimentano la pienezza di vita e una gioia immensa. Una gioia che passa oltre i segni della croce. Certamente è un’esperienza personale. Ma, soprattutto, è un’esperienza comunitaria!
2. Il Risorto chiama la comunità dei discepoli-missionari ad una novità di vita e di servizio.
3. Il dono dello Spirito rende capaci di riconciliare il mondo.
Piste per la preghiera personale: contempla la scena di Gv 20, 19-23 dal punto di vista dell’esperienza comunitaria comunità
= Cosa fa risuonare questa scena dell’esperienza della nostra comunità?
= Quale esperienza del Risorto in mezzo a noi stiamo facendo?
= Dove percepisci il dono dello Spirito? Quali inviti senti ci stia facendo come comunità?
= Il dono della riconciliazione: come siamo chiamati a riconciliarci e riconciliare l’umanità anche con il creato?
Risorse per una riflessione a partire dal Capitolo
Il XIX Capitolo generale ha detto:
«In risposta alle sfide del cambiamento d’epoca che viviamo e alla luce della Parola di Dio, assumiamo l’Ecologia Integrale come un asse fondamentale della nostra missione, che mette in connessione la dimensione pastorale, liturgica, formativa, sociale, economica, politica e ambientale.» (AC ‘22, 30)
= Questa linea guida capitolare chiarisce che non vediamo la conversione ecologica come un progetto umano e, per di più, appiattito sulla dimensione ambientale della realtà. Ma è il cammino di fede percorso assieme, in risposta agli inviti dello Spirito, ascoltando la Parola di Dio e mettendola in pratica.
= Inoltre, è una conversione pastorale verso un approccio ministeriale che parte dalla consapevolezza che tutto è connesso. Ci invita a superare la frammentazione dei nostri impegni e servizi, approdando a pastorali specifiche, dedicate a particolari gruppi umani – soprattutto secondo le priorità continentali (AC ’22, 31) – che connettano le dimensioni pastorale, liturgica, formativa, sociale, economica, politica e ambientale.
= Il Capitolo ha anche assunto l’impegno di
«aderire alla Piattaforma di iniziative Laudato si’, promossa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede (Laudato si’ Action Platform – LSAP) ai vari livelli (comunità, Circoscrizioni, Istituto).» (AC ’22, 30.1)
Per una riflessione a partire dalla Laudato si’
LS 49: «Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano come un’appendice, come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, al momento dell’attuazione concreta, rimangono frequentemente all’ultimo posto. Questo si deve in parte al fatto che tanti professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i loro problemi. Vivono e riflettono a partire dalla comodità di uno sviluppo e di una qualità di vita che non sono alla portata della maggior parte della popolazione mondiale. Questa mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte favorita dalla frammentazione delle nostre città, aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un discorso “verde”. Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.»
1 Infatti, LS 139 dice: «Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.»